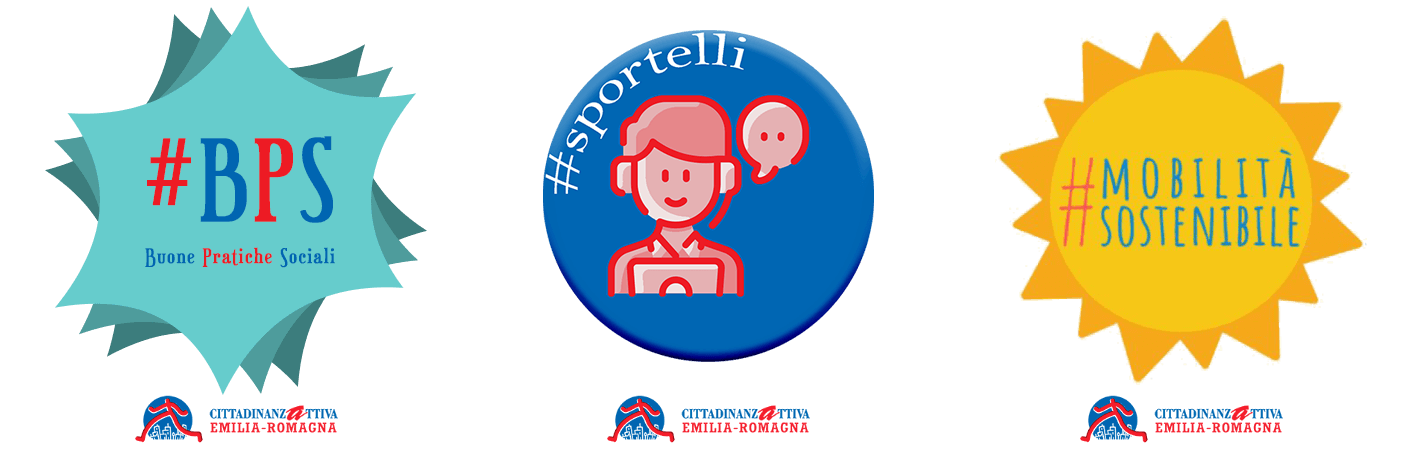di Rossana Di Renzo 1 e Monica Brandoli 2
L’intento del laboratorio “Storie Vagabonde-Bologna tra mappe narrative e urbane: i cittadini raccontano 3 ”era quello di invitare i partecipanti a sperimentare l’incontro tra la mappa della città con la soggettività dell’individuo. Ciò ha permesso un nuovo modo di conoscere la città e condividere esperienze, narrazioni tra persone senza fissa dimora e cittadini/e:
“Quando conosci tutti gli angoli di Bologna, quando li vivi il giorno e la notte, quando conosci le lastre di via indipendenza e i sanpietrini delle stradine del mercato uno per uno allora puoi dire che Bologna è la tua casa”.
“Bologna è la mia casa, non la mia città”.
La casa è ciò che meglio conosciamo e ci appartiene profondamente. Per alcuni dei partecipanti il laboratorio, le strade, i portici di Bologna sono la propria casa. Per molti Bologna è la città in cui si vive, si ritorna, si arriva o si va via. In tutte le narrazioni emerge l’intenso rapporto e una conoscenza profonda con la città e un forte legame di appartenenza:
“Il tuo richiamo è sempre costante anche quando ci si sposta per lavoro o altro”.
Le frasi sono tratte da narrazioni scritte nel laboratorio, che ha utilizzato lo strumento della narrazione. La narrazione, il racconto (orale o scritto), è lo strumento che l’uomo utilizza per attribuire significati e per dare senso alla propria vita e al mondo in cui vive.
Perché storie vagabonde? Perché il vagabondare è un “atto fondativo dell’esperienza”, è una pratica conoscitiva aperta al recupero di un rapporto profondo, intimo e complice con la città. Nelle città non c’è una sola storia, ce ne sono tante. Molto dipende da chi le racconta, e da chi le ascolta. Di ogni luogo esistono diverse narrazioni che spesso sono parallele, s’incrociano e divergono. I luoghi, spesso, rivelano storie che nessuno racconta: le vite di chi le città le abita, le rende attive e le attraversa senza lasciare traccia.
L’attività laboratoriale s’inserisce all’interno di un complessivo lavoro di comunità dedicato alla grave emarginazione adulta, con l’obiettivo di promuovere coesione sociale attraverso il dialogo e una fertile convivenza.
Da alcuni anni il Comune di Bologna insieme ad ASP Città di Bologna, sta lavorando per offrire risposte diverse alla marginalità 4, fuori dalla logica esclusivamente assistenzialista e ciò ha un valore “politico” e una tensione innovativa di cambiamento. Appare banale prendere consapevolezza della necessità di “porre al centro” le persone cosiddette senza dimora ma in realtà comporta e implicherà un processo estremamente complesso e faticoso sia per le persone senza dimora che per gli operatori. Stiamo assistendo a modifiche del tessuto sociale e del “sentire” della popolazione, dove sono in agguato la povertà di appartenenza, la solitudine, la radicalizzazione in una identità che finisce per diventare l’unica accettata e da difendere. Ecco perché è urgente creare spazi di interazione dove i cittadini possano incontrarsi per conoscere, leggere la realtà e trovare modalità di convivenza e valorizzazione che restituisca a tutti la certezza di stare all’interno di un sistema di riferimento valoriale basato sul riconoscimento delle differenze. Se la comunità è in grado di ascoltare, di avvicinarsi alle storie, alle narrazioni delle persone, questo può generare un progetto di azione politica, che rimetta al centro la complessità, la ricchezza dei saperi e dei vissuti individuali e le contraddizioni, e generare una comunità viva e vitale.
Il laboratorio, che è una delle tante risposte messe in campo in questi mesi dal Comune di Bologna, ha visto la partecipazione di persone senza fissa dimora e cittadine/i che hanno raccontato Bologna ripercorrendo la propria storia di vita, contribuendo a raccontare luoghi che spesso viviamo con distrazione o transitiamo velocemente e ai quali non diamo importanza ma che un abitante attento può svelarci attraverso storie vissute o conosciute. Abbiamo disegnato itinerari quotidiani, luoghi che ci hanno emozionato, luoghi dell’identità collettiva, degli incontri, degli scambi, della solidarietà, ma anche di emarginazione e della solitudine. Mappe, tracce inedite che hanno rivelato e ridisegnato la città partendo dalle piccole storie che la costituiscono. Le storie raccontate hanno permesso di riscoprire e vivificare memorie che ci hanno aiutano a riconoscerci e trovare modelli diversi di dialogo e convivenza. Sono state raccontate le vite parallele, quelle storie di vita che altrimenti andrebbero perse, perché inascoltate o perché invisibili o storie vitali, di passione, che si prendono cura della città.
Il senso di appartenenza alla città
La città è lo scenario entro cui realizziamo la nostra vita e si muovono i destini dell’uomo. La città è condensazione e concentrazione di tempo di vita e tempo storico. I diversi percorsi che facciamo quotidianamente rispecchiano la nostra vita ed anche le nostre scelte individuali. La città cambia, si trasforma e accompagna il fluire delle nostre “stagioni” non sempre in sintonia con quello che accade ma è come se una sorta di “perdono” ammantasse tutto:
“Sai è da diverso tempo che ti vivo, osservandoti. Ti trovo cambiata nel tempo e non sempre in meglio, nonostante tutto mantieni il tuo fascino”.
“Cara bologna purtroppo non ti riconosco più. Sei cambiata dagli anni in cui ho vissuto la mia giovinezza. Ora vedo una città del 3° millennio che è più frivola e meno acculturata”.
“Una volta eri magica e piena di sogni oggi nel tuo essere vera sembri così finta impostata”.
“E poi basta con tutti questi baretti sembri diventata un Mac Donald del tipico!”.
“Dove sono finite la tua ironia e la tua goliardia, seriosa non sei bella, ma sei comunque meglio di tante”.
Raccontiamo, ascoltiamo storie della città e della nostra vita. In tutto questo c’è qualcosa di essenziale e di profondo: l’ininterrotto e fascinoso tentativo di portare a parola il senso del nostro stare nel mondo e al mondo. L’individuo che attraversa spazi urbani, li intreccia con la sua esperienza di vita, intima come i ricordi, con il senso di appartenenza e la creatività del narratore.
La città è luogo di confronto, dove è possibile intervenire attivamente e creativamente nella costruzione di senso; una città aperta permette l’interazione tra mondo soggettivo/individuale e mondo sociale. Con la città s’intesse una trama feconda e profonda di sentimenti spesso contrastanti:
“Ti scrivo per portarti con me. Portarmi dentro l’idea di me in te”.
“Sei protettiva come un guscio ma sei anche un limite con il tuo provincialismo e con il tuo qualunquismo”.
“Per ricordarmi che ci sei. Che il tuo nome è già un concetto”.
“Raccogliere nei miei pochi passi le storie che trasudano dai muri, dai portici, dalle piazze. I luoghi alla fine raccontano attimi di vita delle persone. Bologna mi aspetti, per questo torno sempre”.
“Tutti i portici di cui parlano e i luoghi di una volta quest’ oggi rigettati in pasto alla solitudine valgono l’idea stessa di ritornare da te”.
La città è una città, un insieme impreciso di cose, persone, culture ed ineguaglianze:
“Le crudezze della vita vivono solo di notte, la città di giorno è scintillante”.
Il rapporto con il cibo è importante, ma più importante è con chi lo condividiamo. Il cibo è sinonimo di cultura e di convivialità:
“Non puoi stare lontano dalle tagliatelle al ragù, dai tortellini in brodo, dalla mortadella e da tutto quello che è “arte culinaria bolognese”.”
Il luogo del cuore
La città, per colui che l’attraversa, è anche fatta di narrazioni, il cui valore può risiedere nel trasmettere i differenti saperi di cui il luogo è portatore. In questo modo il paesaggio urbano si ricostruisce e arricchisce di narrazioni collettive, narrazioni vive, dinamiche che ci permettono di riappropriarci di luoghi, di vite vissute. Ci sono luoghi a cui siamo particolarmente legati:
“Il mio luogo del cuore a Bologna è la Stazione Centrale dei Treni. Un posto insolito ma pieno di fascino perché di giorno si riempie di persone, di saluti, partenze, viaggi e ritorni. Di giorno i tunnel sono calpestati da migliaia di persone che rincorrono i loro treni, C’è fretta di arrivare, c’è fretta di tornare, si è immersi nei propri pensieri nei propri problemi. La notte la stazione si trasforma e cambia scenario, compaiono gli invisibili. Di notte negli angoli bui e freddi s’intravedono visi stanchi e affaticati dalla vita. Vita di strada, quella fatta di pericoli, fatica e solitudine. Grazie ad una mia esperienza di tirocinio al servizio Help Center all’interno della Stazione, sono riuscita nel tempo a dare un volto, un nome e una storia a tutte quelle persone che vivono in Stazione”.
“I vicoli e i portici di Bologna sono molto presenti nel mio cuore. Però quando mi chiederanno qual è stato il luogo del cuore nel primo anno di vita in città, li accompagnerò sul ponte Stalingrado. Accanto al ponte c’è il mio studentato, un angolo di paradiso: via Masi 22…Ricordo quel gennaio del 2015, quando tutti aspettammo che si formasse un bel gruppo di persone sotto il ponte di Stalingrado. Anziani e giovani ci afferrammo per mano e salimmo in verticale tutti quei gradini ghiacciati. Fu in quell’instante, quel tenersi per mano che mi si sciolse il cuore. Mi sembrava che non mi mancasse più nulla e null’altro chiedevo al mio presente…Andate a visitare quelle case piene di vita di sogni e di speranze”.
“Via Andrea Costa 150 è la strada in cui sono nato e dove sono nate le prime amicizie scolastiche, i primi sport, i primi amori, i primi approcci alla sessualità. I ricordi più belli collegati alla strada sono quelli riguardanti mia madre e mio padre e la cura che hanno avuto nell’educarmi e nel trasmettermi valori per me importanti”.
“Il luogo del mio cuore, il posto dove ho lasciato una parte della mia anima, è un insulso quadretto di cemento e fango situato tra via Gobetti e il canale navile. Là, vicino alle macerie di una vecchia fornace, a pochi passi dalle scuole Grosso, assieme alla mia famiglia ho vissuto quasi tutti i primi dieci anni della mia vita. Se solo chiudo gli occhi, rivedo i volti e le mille storie di tutte le persone che vivevano là. Quel luogo, come dicevo, per molti era un posto insulso fatto di fango, pozzanghere, macerie ed una puzza incredibile che veniva dal vicino canale soprattutto d’inverno. Per me, che invece l’ho vissuto, era il posto più bello del mondo. Ma non provate a cercarlo sulle mappe, perché quel luogo da qualche anno non esiste più. O meglio, esiste solo nel mio cuore assieme a tutte le storie di cui sono stato testimone”.
Così ci siamo narrati così ci siamo conosciuti. Abbiamo raccontato e abbiamo ascoltato storie, affascinati e che ci hanno incantato: le nostre storie, le storie degli altri. Storie, bellissime storie, che ci hanno iniziati ad un senso del mondo e accompagnati nell’incontro con gli altri.
Da qui l’idea di avviare una start up di guide turistiche con persone senza fissa dimora e giovani che racconteranno una Bologna intima, personale che s’intreccia con la cultura, la storia e il sociale. Se vi abbiamo incuriosito vi attendiamo a settembre per partire con noi in un viaggio di storie, le più belle possibili , con colpi di scena, e poi sempre storie, dentro ad altre storie, circondati da mille storie che potrete incrociare e conoscere con noi e perché no, arricchirle con le vostre storie.
1 Rossana Di Renzo, Esperta in metodologie autobiografiche, formatasi presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, ross.direnzo@gmail.com.
2 Monica Brandoli, Responsabile Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta – ASP Città di Bologna, monica.brandoli@aspbologna.it
3 Il Laboratorio progettato e condotto da Rossana Di Renzo, si è svolto da settembre 2017 a maggio 2018 presso Laboratorio 051. Hanno partecipato persone senza fissa dimora e cittadine/i.
4 Le persone senza dimora spesso si adattano ai servizi e chiedono ciò che i servizi possono dare. In questa esperienza invece stiamo provando ad adattare il servizio alle loro aspettative. Questo movimento nuovo si sta riverberando sul contesto sociale, in particolare nelle aree dove i laboratori sono collocati. E’ un movimento sempre a rischio di attacchi di intolleranza ma che presenta anche tanti spazi di apertura e di vicinanza. Stiamo assistendo al passaggio dal “capitale umano”, centrato su un forte investimento sul singolo, al “capitale sociale” dove sono le risorse relazionali il valore profondo. Stiamo assistendo a modifiche del tessuto sociale e del “sentire” della popolazione, dove sono in agguato la povertà di appartenenza, la solitudine, la radicalizzazione in una identità che finisce per diventare l’unica accettata e da difendere . Le periferie non sono solo luoghi geografici ma stanno diventando una modalità di essere, di vivere le città e le relazioni. Ecco perché è urgente creare spazi di interazione dove le diverse comunità possano incontrarsi, dove i cittadini – tutti – possano essere aiutati non a trovare soluzioni, spesso troppo facili, ma a costruire problemi insieme e a leggere la realtà condividendo le stesse regole del gioco che deve essere basato essenzialmente sul restituire a tutti la certezza di stare all’interno di un sistema di riferimento valoriale basato sul riconoscimento delle differenze , dove non esistono individui inferiori, dove le differenze non vengono rimosse ma le pluralità vengono regolamentate. Uguaglianza quindi non come omogeneizzazione ma uguale possibilità di espressione di sé. Uguaglianza come uguale possibilità di essere differenti, di avere diverse opinioni, dove nessuna differenza è migliore delle altre.
In apertura: foto tratta da Pixabay.com, @gustavozini