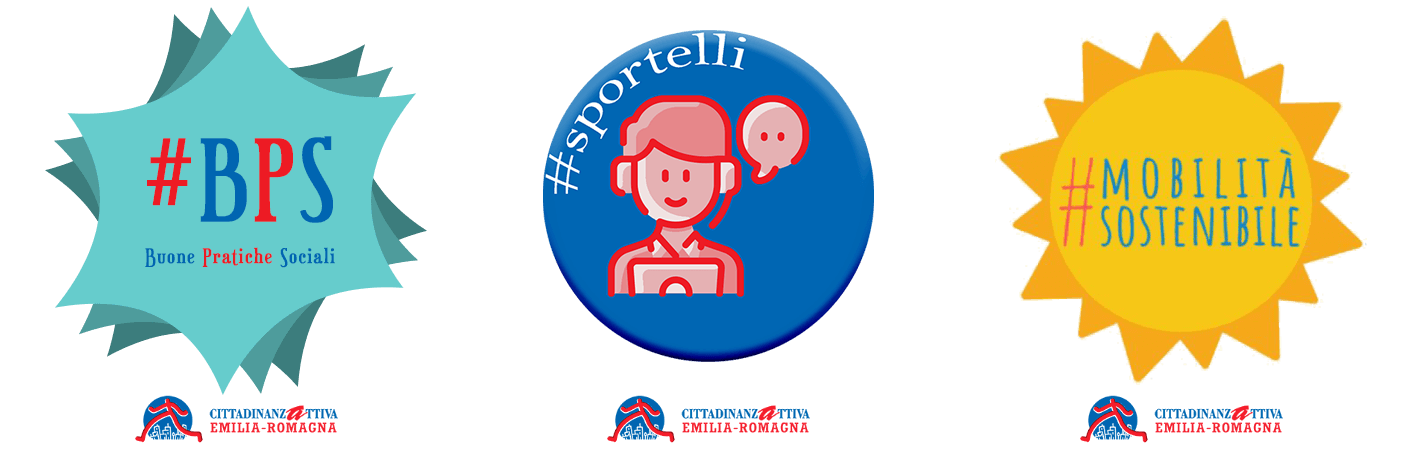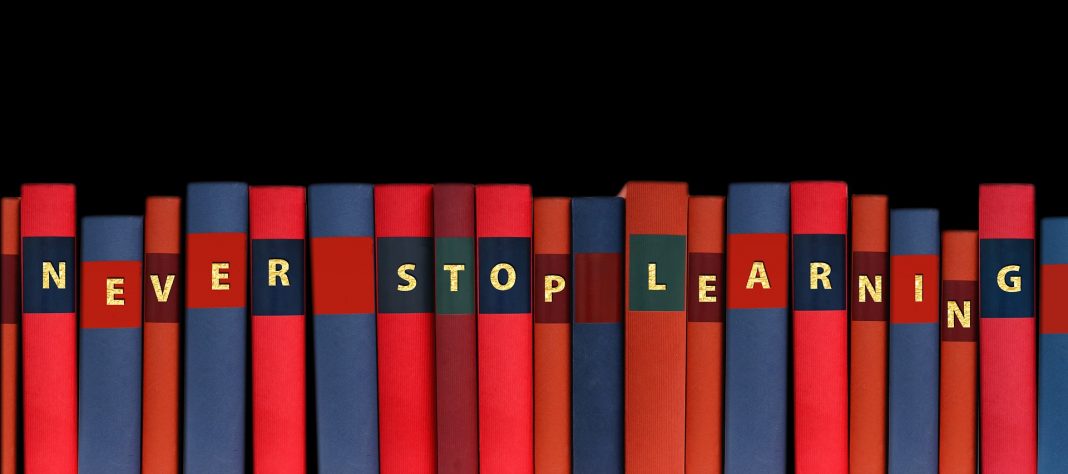a cura di Federico Licastro
Il virus circola attivamente in Italia e sono presenti varianti con maggior potenziale infettivo.
Si può continuare nel lock-down delle attività economiche e sociali? Evidentemente no, pena il tracollo economico del nostro paese. Le conseguenze potrebbero essere molto più pesanti, poiché alcuni settori quali la ristorazione, il turismo e lo spettacolo che contribuiscono per una notevole percentuale all’economia nazionale continuano a vivere i giorni più incerti di questo inizio secolo.
Si registra un accresciuto impoverimento di molte fasce della popolazione italiana che già prima dell’inizio della pandemia vivevano in condizioni precarie e con scarse prospettive di riscatto e conomico-sociale.
conomico-sociale.
Covid e attività didattiche
Le scuole hanno nuovamente chiuso le attività didattiche in presenza e l’offerta formativa ancora si limita alla didattica a distanza. Le attività didattiche via web con lezioni dal vivo o lezioni preregistrate sono ormai la norma per tutti i gradi di istruzione ed è stato offerto in questo modo ai bambini e ai ragazzi un certo grado di continuità didattica.
Emergenza pandemia e DAD
I pregi e i difetti di tale modalità di insegnamento saranno sicuramente oggetto di studi e indagini nei mesi futuri e forse sapremo qualcosa di più sulla qualità degli insegnamenti somministrati, sul gradimento da parte degli studenti e sull’efficacia formativa di questo approccio emergenziale.
Ma già oggi si capisce che questa modalità di istruzione priva della socialità i ragazzi e espone i più fragili ad accumulare deficit in formazione che non si sa quando e come recuperare.
Sappiamo anche che molti studenti di ogni ordine, età e grado non hanno potuto seguire queste modalità di didattica perché sprovvisti di ausili elettronici appropriati o di connessione web o per altre ragioni di esclusione socioeconomica. Quindi, è facile immaginare che in questo periodo siano aumentate le diseguaglianze in ambito scolastico sulla base della sola possibilità di usufruire del servizio didattico di emergenza offerto in modalità telematica.
Tuttavia, il danno è stato senza dubbio più profondo se consideriamo la scuola come mondo di interazioni, rapporti sociali e di apprendimento non solo nozionistico.
E in Europa?
In altri paesi la chiusura delle scuole è stata più breve e alcuni servizi non hanno mai chiuso.
Ad esempio, in Francia sono stati istituiti apposite strutture che hanno accolto i figli dei lavoratori “essenziali” medici, infermieri lavoratori delle catene distributive ecc. durante le ore lavorative dei genitori.
In Olanda gli asili e le scuole materne non hanno praticamente mai chiuso e si sono presi cura dei bambini i cui genitori non potevano farlo per motivi di lavoro.
In Svezia le scuole sono rimaste aperte accogliendo i bambini e i ragazzi che volevano frequentare su base volontaria anche durante i picchi epidemici più elevati.
In Germania con ampia discrezionalità dei singoli Lander si sono riaperte le scuole dopo un breve periodo di chiusura cominciando dalle realtà regionali dove l’indice epidemico era più contenuto.
Chi si è preso cura e ha dato continuità formativa ai figli dei “nostri eroi” cioè di medici, infermieri forze dell’ordine e lavoratori dei settori essenziali che non si sono fermati durante il lock-down?
Probabilmente quando possibile le mamme, le sorelle e i fratelli più grandi o le nonne e i nonni o altri parenti.
Ai nostri giovani cittadini durante la pandemia sono stati disconosciuti molti diritti e ancora di più i diritti alla formazione e all’educazione.
In Italia oggi sappiamo che le scuole rimarranno chiuse fino fine marzo. Nulla sappiamo ancora sulle modalità degli esami della terza media e se gli esami delle superiori saranno in presenza e con quali modalità.
Le altre attività formative quali laboratori, attività sportive, attività musicali e artistiche si sono volatizzate determinando un degrado della qualità formativa e un impoverimento culturale e formativo grave per tutti gli studenti di ogni età.
Soprattutto nulla sappiamo di come, quando e quanto saranno avviate a soluzione le varie criticità che affliggevano la scuola italiana prima dell’avvento del virus. Ad esempio, la qualità della didattica, i laboratori didattici, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l’adeguamento delle strutture sportive scolastiche alle varie norme di sicurezza.
Si stanno distribuendo risorse economiche di una certa consistenza sotto forma di bonus baby-sitter, ma asili e scuole materne rimangono chiuse anche per chi ne avrebbe assoluto bisogno.
Forse il virus risparmia la baby-sitter a pagamento, ma colpisce le maestre? Non ci sono dati scientifici a questo riguardo e le scelte effettuate sembrano del tutto arbitrarie.
La scuola e i vaccini
Fortunatamente sono arrivati i vaccini. Diversi vaccini sono già ora disponibili e la campagna vaccinale ha già coperto gli operatori sanitari e i ricoverati nelle RSA. Le vaccinazioni proseguono fra alti e bassi e si sta vaccinando il personale dell’esercito e quello di polizia e contemporaneamente gli anziani ultra-ottantenni e via giù con i settantacinquenni, i settantenni e così via. Fra le priorità vaccinali vi sono anche i professori e il personale della scuola e università.
Ma i vaccini sono un mistero per i giovani e i bambini. Gli studi di validazione dei vaccini non hanno incluso persone sotto i sedici anni perché da questa fascia di età in giù il rischio di ammalarsi con gravi conseguenze era minimo fino a pochi mesi fa. Ma se il virus continuando a mutare diventasse più aggressivo per le fasce giovanili? Nessuno sa se e quando la vaccinazione anti Covid-19 coprirà prima o poi i giovani e i bambini.
Questa lacuna è grave poiché lasciando una fetta consistente della popolazione scoperta si lascia libera circolazione al virus che può continuare a mutare con effetti imprevedibili sulla salute pubblica.
Sarà questa l’ennesima prossima scusa per continuare a mantenere le scuole chiuse?
Non abbiamo ancora dati scientifici, ma si sono fatte e si fanno scelte senza una solida base scientifica che hanno pesato molto e continueranno a pesare sulla vita sociale e formativa dei bambini e dei ragazzi italiani, soprattutto quelli più disagiati.
Aumentano così le diseguaglianze con buona pace di chi per mandato al governo ci dovrebbe stare per farle diminuire.
Dei miliardi di euro che saranno sicuramente spesi nei prossimi mesi anche attingendo da fondi europei, quanti verranno spesi per la scuola e l’università e quali saranno i progetti per migliorare la didattica per i nostri giovani cittadini?
Il miglioramento della qualità della didattica e la revisione dei progetti formativi devono essere obbiettivi prioritari nel riassetto della scuola e dell’università italiane.
I dati disponibili relativi alla qualità della didattica del 2017 ci vedono quattordicesimi su diciassette paesi europei dopo Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Spagna e seguiti solo da Croazia, Grecia e Romania. L’Italia è ben venti punti sotto la media dei 28 paesi della UE.
L’istruzione è la cenerentola italiana.
Quali sono le ragioni che ci possono aiutare a capire perché l’istruzione in generale è sempre stato un settore trascurato da quasi tutti i governi al di là dei colori politici?
Le ragioni sono molte e la realtà del mondo della scuola è complesso e articolato. Tenterò solo di abbozzare alcune dei motivi che possono in parte spiegare la situazione di grave disagio che colpisce l’istruzione italiana.
Anche nel mondo della scuola notiamo un connubio di interessi e responsabilità gestionali diverse fra istituzioni che comprendono lo stato centrale, le regioni, le provincie o ciò che ne rimane e i comuni. Questa frammentazione di responsabilità e di compiti operativi sulla scuola e le università in parte contribuisce alla inerzia nelle scelte e alla lentezza con cui si affrontano i problemi urgenti dell’istruzione in Italia.
A esempio le regioni e i comuni hanno responsabilità preminenti sugli asili nido e sulle scuole materne a gestione comunale e/o regionale. D’altra parte, lo stato (ministero dell’istruzione) ha responsabilità preminenti per la gestione delle scuole materne statali, delle elementari, di quelle medie, delle scuole superiori e delle università.
Ma le competenze gestionali si intersecano e si intrecciano quando si considerano le scuole elementari e medie a tempo pieno (dove ancora questa modalità sopravvive), poiché le competenze per il servizio mensa sono ad esempio comunali.
Ma ancora dobbiamo considerare che l’edilizia scolastica è spesso competenza dei comuni, provincie e regioni, come pure la conformità degli impianti di servizio (elettrici etc.) e di quelli sportivi.
Scuole aperte o chiuse? chi lo decide?
Quindi a secondo delle esigenze e delle inclinazioni delle diverse realtà politiche decentrate si è assistito alla chiusura delle scuole superiori e delle università, mentre rimanevano aperti gli asili, e la scuola primaria. Forse perché le responsabilità locali sono più dirette? E il panorama nazionale assumeva i colori arlecchineschi del regionalismo.
I fatti ci dicono che il virus può infettare bambini e ragazzini così come gli adolescenti e i giovani e da qui circolare in famiglia e aumentare i contagi. Quindi che senso ha tenere aperte le scuole primarie e chiudere le secondarie?
Si è ancora una volta presentato un conflitto fra lo stato centrale e le regioni anche nella gestione delle aperture e chiusure delle scuole anche se le discrepanze verificatesi in questo settore hanno suscitato un interesse limitato alle famiglie più colpite.
Nel mondo della scuola troviamo un altro punto di debolezza istituzionale per come si sono articolate e distribuite le responsabilità politiche con il regionalismo che non è solo sanitario, ma si coniuga in campi più numerosi e complessi.
Lo scarso dialogo fra stato centrale e regioni nella gestione dell’istruzione non è un fatto recente ma risale a molti decenni col risultato che è sotto gli occhi di tutti; non solo durante la pandemia l’istruzione ha registrato un crollo, ma è nota la decadenza scolastica pre-pandemica che caratterizza il nostro paese e ci pone come fanalino di coda nei paesi OCSE.
I giovani hanno potere?
Che dire? Stato centrale, regioni provincie e comuni sanno bene che i bambini, i ragazzini e gli adolescenti non votano, quindi si possono trascurare perché le priorità sono sempre altre.
Questo approccio condiviso fra le istituzioni così dette democratiche e i governi di tutti i colori che si sono succeduti negli ultimi venti cinque anni hanno causato una scarsità di investimenti in istruzione che ci colloca fra gli ultimi paesi europei.
La sicurezza degli edifici scolastici rimane un obbiettivo ancora lontano e spesso intonaci e muri crollano con effetti rovinosi.
La scuola a tempo pieno dalle elementari in su sta lentamente scomparendo.
I licei soffrono di una cultura formativa asfittica che era già vecchia nel secolo scorso e non comprende cosa sono oggi gli adolescenti nell’era della comunicazione elettronica e di internet.
L’Università gode ancora di isole felici da punto di vista della ricerca, ma si sta trasformando sempre più in un liceone di grado superiore con strutture, aule e strumenti poco adeguati al bisogno dei tempi.
Infine, quando si riesce a formare i giovani con laurea o addirittura dottorati ecco che lasciamo che a decine di migliaia abbandonino il nostro paese per cercare una migliore collocazione lavorativa in altri paesi europei e extra europei che si vedono piovere addosso la manna di giovani formati a costo zero.
Questo è il segno più evidente dell’arretratezza del nostro paese che non sa come impiegare schiere di giovani formati e pieni di speranza.
Tuttavia, il rinnovamento sperato dal “Next Generation UE”, impropriamente ribattezzato dai nostri politici Recovery Plan, non lo potranno fare i settantenni che affollano i consigli di amministrazione di aziende, banche e strutture finanziarie del nostro paese.
Ancora continueremo a pensare che la ricerca è un lusso e che con la cultura non si mangia o simili amenità da ignoranti?
Se il futuro è solo l’oggi, il nostro paese continuerà a sprofondare in un lento declino che ci condannerà alla marginalità in Europa e nel mondo.
Solo investendo in modo consistente in cultura, istruzione e formazione potremo avviare un ciclo nuovo e uscire dalle difficoltà in cui ci dibattiamo da decenni.
Il prezzo delle donne durante la pandemia
Anche la parità di genere oggi finalmente tornata alla ribalta non la si potrà migliorare se non si aumenta la disponibilità di servizi scolastici in tutti i gradi formativi che prevedano il tempo pieno su tutto il territorio nazionale.
Fino a che l’occupazione femminile sarà scarsa e marginale il paese non potrà esprimere appieno le potenzialità del proprio capitale umano. Le donne potranno finalmente essere cittadine, lavoratrici e se lo vorranno anche mamme senza che una delle tre condizioni influenzi negativamente le altre due?
Giovani e disoccupazione
Dovrà essere sostanzialmente migliorata anche l’integrazione dei giovani nel tessuto economico creando opportunità di occupazione e di formazione al lavoro in settori oggi trascurati e investendo in innovazione. Non possiamo più permetterci livelli di disoccupazione giovanile scandalosi che ci condannano ad una decadenza inesorabile.
Attualmente, la marginalità della scuola nel confuso dibattito sociale, economico e politico della fase di perdurante pandemia non promette bene. Speriamo che si recuperi sostanzialmente e velocemente durante nella fase vaccinale e che diventi centrale per l’attuazione del Next Generation UE.
Tuttavia, senza una forte pressione civica anche questo nuovo governo che vede Mario Draghi impegnato in prima persona potrebbe dimostrarsi insufficiente.
Per approfondire:
La ricerca universitaria durante la pandemia in Italia:https://www.cittadinanzattiva-er.it/la-ricerca-universitaria-durante-la-pandemia-in-italia/
Per una scuola sicura innovata cittadinanzattiva emilia romagna si mobilita: https://www.cittadinanzattiva-er.it/per-una-scuola-sicura-rinnovata-cittadinanzattiva-emilia-romagna-si-mobilita/
Foto:Pixabay