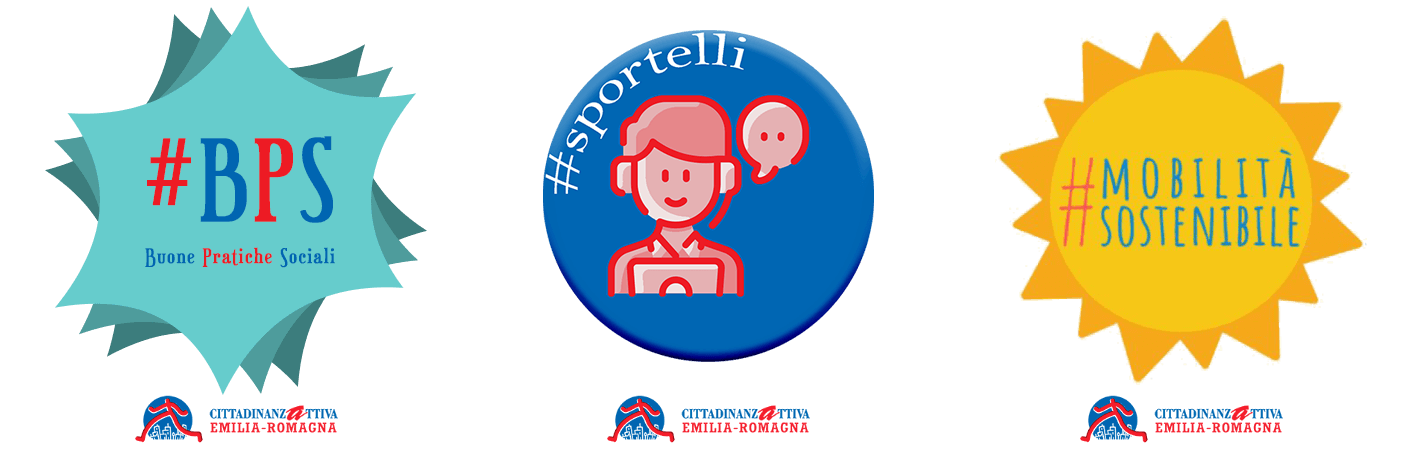di Walther Orsi
In questi ultimi tempi l’inquinamento ambientale è diventato uno dei problemi prioritari dell’umanità. Ma cosa è l’inquinamento ambientale? Si intende la presenza di elementi inquinanti nei differenti comparti costituenti l’ambiente naturale: atmosfera, acqua, terreno. Tali elementi sono di vario genere: gas, polveri, residui di combustione, liquidi, radiazioni elettromagnetiche, sostanze radioattive, rumori, vibrazioni. A parte l’inquinamento causato da eruzioni vulcaniche, ad inquinare l’ambiente è sempre la mano dell’uomo. Le principali fonti di inquinamento derivano da: processi industriali, traffico, impianti di incenerimento rifiuti, centrali termoelettriche, raffinerie petrolifere, lavorazione del ferro e della plastica, utilizzo dei fertilizzanti chimici, produzione di scorie nucleari, riscaldamento, agricoltura intensiva, incendi di boschi e foreste.
E’ sempre più evidente che l’inquinamento, oltre a trasformare, impoverire e danneggiare l’ambiente naturale, incide negativamente sulla salute dell’uomo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), nel vecchio continente, 9 cittadini su 10 sono esposti a livelli troppo alti di inquinamento.
Il rapporto del GEO (Global Environment Outlook), prodotto dal Programma Ambiente delle Nazioni Unite sullo stato di salute del pianeta, è un vero e proprio allarme perché l’inquinamento provoca più di un quarto delle malattie e delle morti nel mondo, mettendo a rischio gli ecosistemi, con gravi conseguenze sull’economia globale. In particolare l’inquinamento atmosferico provoca dai 6 ai 7 milioni di morti premature l’anno. Inoltre le emissioni di gas serra favoriscono i cambiamenti climatici danneggiando ulteriormente le vite di miliardi di persone (la Repubblica 13.3.2019).
Fenomeni meteorologici

Le conseguenze dei cambiamenti climatici interessano tutte le regioni del mondo, con fenomeni meteorologici sempre più estremi e frequenti, quali siccità e ondate di calore. Il riscaldamento globale provoca lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento dei mari causando allagamenti e fenomeni di erosione lungo le regioni costiere basse. I cambiamenti climatici si stanno verificando a ritmi talmente veloci che numerose specie animali e vegetali stentano ad adattarsi. Molte specie terrestri, marine e di acqua dolce si sono già spostate verso altre zone. Alcune specie vegetali e animali saranno esposte ad un maggior rischio di estinzione se la temperatura media mondiale continuerà ad aumentare in maniera incontrollata. Queste alterazioni nel funzionamento degli ecosistemi si ripercuotono ovviamente sulla società, il cui benessere dipende direttamente dalla salute degli ecosistemi.
Se questo è particolarmente vero per i paesi in via di sviluppo, in cui le popolazioni dipendono fortemente dal loro habitat naturale e dispongono di pochissime risorse per adattarsi al cambiamento, le prospettive non sono rosee neppure in Occidente e in particolare in Europa. Nella zona centro-meridionale si registrano ondate di calore, incendi e siccità sempre più frequenti. Il Mediterraneo si sta trasformando in una regione arida. L’Europa settentrionale sta diventando sempre più umida e le alluvioni invernali potrebbero diventare un fenomeno ricorrente. Le zone urbane, in cui vivono 4 europei su 5, sono particolarmente esposte ad ondate di calore, alluvioni e all’innalzamento del livello dei mari dovuti al calore. I cambiamenti climatici determinano gravi costi per la società e l’economia.
 Tra il 1980 e il 2011 le alluvioni hanno colpito più di 5,5 milioni di persone, provocando perdite economiche dirette per 90 miliardi di euro. I settori economici più colpiti sono l’agricoltura, la silvicoltura, l’energia e il turismo.
Tra il 1980 e il 2011 le alluvioni hanno colpito più di 5,5 milioni di persone, provocando perdite economiche dirette per 90 miliardi di euro. I settori economici più colpiti sono l’agricoltura, la silvicoltura, l’energia e il turismo.
La sfida ai cambiamenti climatici coinvolge in primis le istituzioni (organizzazioni internazionali, paesi, enti locali), chiamate ad adeguare le loro politiche, ma anche i cittadini, che possono fare la differenza cambiando i loro stili di vita.
Per quanto riguarda le azioni di adattamento, secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), si possono individuare alcuni esempi in vari ambiti.
Sviluppo umano: migliore accesso all’istruzione, all’alimentazione, alle strutture sanitarie.
Riduzione della povertà: migliore accesso e controllo delle risorse locali; reti di sicurezza sociale e protezione sociale.
Sicurezza dei mezzi di sussistenza: miglior accesso alla tecnologia e ai forum decisionali; miglioramento delle pratiche di coltivazione, allevamento e acquacoltura.
Gestione dei rischi di catastrofi: installazione di sistemi di allarme rapido; diversificazione delle risorse idriche; costruzione di rifugi per inondazioni e cicloni; adeguamento dei codici e pratiche di costruzione; miglioramento delle infrastrutture di trasporto e stradali.
Gestione dell’ecosistema: mantenimento di zone umide e spazi verdi urbani; rimboschimento costiero; gestione dei bacini idrici; riduzione della frammentazione dell’habitat; mantenimento della biodiversità.
Pianificazione territoriale: fornitura di alloggi, infrastrutture e servizi adeguati; gestione dello sviluppo in aree soggette a inondazioni e altre aree ad alto rischio; pianificazione urbana e programmi di riqualificazione; adeguamento delle leggi sulla zonizzazione della terra; mantenimento delle aree protette.

Energia: maggiore diffusione delle energie rinnovabili, riduzione della dipendenza da combustibili fossili.
Trasporti: utilizzo di carburanti a basso contenuto di carbonio e biocarburanti.
Industria: processi di riduzione delle emissioni; riutilizzo dei rifiuti; trasferimento dai combustibili fossili a combustibili a basse emissioni di carbonio o biomassa.
Insediamenti: maggiore utilizzo di energie rinnovabili; mantenimento del mix di usi del suolo (es. funzioni commerciali e residenziali a breve distanza le une dalle altre).
Agricoltura e foresta: riduzione delle emissioni di metano (ad es. migliore gestione del bestiame) e protossido di azoto (gestione di concime e letame); riduzione della deforestazione e del degrado forestale, prevenzione degli incendi.

Trasporto: evita di guidare quando possibile; preferisci i mezzi pubblici, la bicicletta, o il cammino; se hai bisogno di un’auto, cerca delle alternative come il car sharing, o il car pooling per ridurre al minimo l’impatto climatico della tua guida; evita i brevi viaggi in aereo e prendi invece l’autobus o il treno (secondo l’International Civil Aviation Organization (ICAO) Carbon Emission Calculator e l’EPA Green Equivalencies Gas Equivalencies Calculator, un viaggio di andata e ritorno da New York a Boston per una persona in classe economica equivale a 62 ettari di carbonio catturato dalle foreste degli dagli Stati Uniti in un anno!)
Energia: spegni le luci nelle stanze vuote; usa prese multiple e prolunghe con interruttore, per accendere e spegnere gli apparecchi quando necessario; in alternativa, scollega le apparecchiature elettroniche quando non in uso; spegni il riscaldamento e l’aria condizionata in stanze inutilizzate; sostituisci le lampadine con quelle a LED; investi in apparecchi ad alta efficienza energetica (es. soffioni doccia, rubinetti e servizi igienici a basso flusso); asciuga i vestiti in modo naturale ogni volta che è possibile anziché utilizzare l’asciugatrice; scongela regolarmente il frigorifero e il congelatore.
Domestico: evita di fare docce lunghe e troppo calde (secondo l’Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti, lasciare funzionare il rubinetto per cinque minuti per riscaldare l’acqua consuma circa quanta energia consente di far funzionare una lampadina da 60 watt per 14 ore); metti un coperchio sulla padella mentre stai cucinando. Regola adeguatamente il termostato; chiudi il rubinetto mentre ti radi, o ti lavi i denti.
Stile di vita: mangia meno carne rossa, pollame e pesce e aumenta le opzioni vegetariane (un chilo di carne bovina consumata negli Stati Uniti emette 27 kg di CO2 equivalente, ossia quanta ne viene emessa guidando un veicolo medio per 106 km); prova ad acquistare prodotti locali il più possibile (in questo modo si riduce non solo l’impronta di carbonio associata al viaggio del cibo dal campo al piatto, ma si sostiene e si rinforza anche l’economia locale); riduci al minimo gli sprechi alimentari cercando di preparare solo ciò che consumerai.; utilizza una bottiglia d’acqua riutilizzabile; porta le tue borse riutilizzabili quando vai a fare shopping; metti un timer nella doccia per ridurre al minimo il consumo di acqua.
Posto di lavoro: spegni le luci in stanze inutilizzate; Spegni il computer e il monitor quando lasci l’ufficio; evita di stampare il più possibile; porta la tua tazza, bottiglia d’acqua e posate riutilizzabili; cerca di usare i mezzi pubblici, o vai in bicicletta e, se ciò non fosse possibile, prova a verificare se è possibile il car pooling (condividere il viaggio in auto con i colleghi).
Per meglio comprendere l’evoluzione delle azioni istituzionali e individuali tese a fronteggiare i problemi dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e della cura dell’ambiente, può essere utile rappresentare brevemente la storia degli accordi internazionali in tali ambiti.

Rio 1992 – COP 1 (Conference of the parties)
La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è il primo e principale trattato internazionale che ha puntato alla riduzione delle emissioni di gas serra e viene stipulato a Rio de Janeiro nel 1992. Questo accordo ha un carattere non vincolante dal punto di vista legale, nel senso che non impone limiti obbligatori alle emissioni di gas serra alle singole nazioni firmatarie.
Protocollo di Kyoto
E’ il primo documento internazionale che ha imposto l’obbligo di riduzione delle emissioni ai paesi sviluppati: un – 5% nel primo periodo di adempimento compreso tra il 2008 e il 2012, con l’Unione Europea che ha fissato un’ulteriore riduzione del -8%.
Il secondo periodo di adempimento è iniziato nel 2013 e si concluderà nel 2020, durante il quale i paesi firmatari si sono impegnati a ridurre le emissioni del -18% rispetto ai livelli del 1990. L’UE ha fissato una percentuale invece del -20%. Gli Stati Uniti non hanno mai aderito al Protocollo di Kyoto ed altri paesi (Canada, Russia, Giappone e Nuova Zelanda) non si sono impegnati per il secondo periodo. L’Accordo si applica quindi solo per circa il 14% delle emissioni mondiali.
Accordo storico di Parigi – COP 21
Ha prodotto il primo testo universale per ridurre la temperatura di 2 gradi dal 2015 al 2100 (ovvero un taglio dell’ordine tra il 40% e il 70% delle emissioni entro il 2050). L’Accordo di Parigi è entrato in vigore nel 2016, in seguito all’adempimento delle condizioni per la ratifica da parte di almeno 55 paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali di gas serra. Tutti i paesi dell’UE hanno ratificato l’accordo che ha avuto il pregio di esser il primo di carattere vincolante e di portata globale per il contrasto ai cambiamenti climatici.
Conferenza ONU sul clima di Bonn 2017 – COP 23
In tale contesto è nata l’Alleanza globale per lo stop al carbone e sono stati fissati obiettivi più ambiziosi per la produzione di energie rinnovabili. Hanno aderito anche Cina e India con i loro rispettivi 1,4 e 1,1 miliardi di abitanti. Gli Stati Uniti invece si sono svincolati dagli Accordi di Parigi.
Vertice ONU sul clima, tenuto a New York il 23 settembre 2019
Ha rappresentato un Summit per certi versi deludente perché nessuno dei principali Paesi emettitori si è impegnato a fare di più per limitare l’introduzione di nuovi inquinanti in atmosfera. In tale occasione ci sono state anche delle buone notizie: 77 piccoli paesi hanno annunciato il loro impegno a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 e altri 70 si sono posti obiettivi di riduzione ancora più ambiziosi di quelli presi con gli Accordi di Parigi. Un importante contributo è arrivato dal mondo della finanza e delle aziende, che proveranno a presentare piani finanziari improntati ad emissioni zero entro il 2050. Infine, più denaro è entrato nelle casse del Green Fund, il fondo destinato ad aiutare le nazioni in via di sviluppo nelle questioni climatiche: grazie all’impegno di Svezia, Danimarca, Norvegia e Svizzera, che hanno raddoppiato il proprio contributo, ora sono stanziati 7 miliardi di dollari.