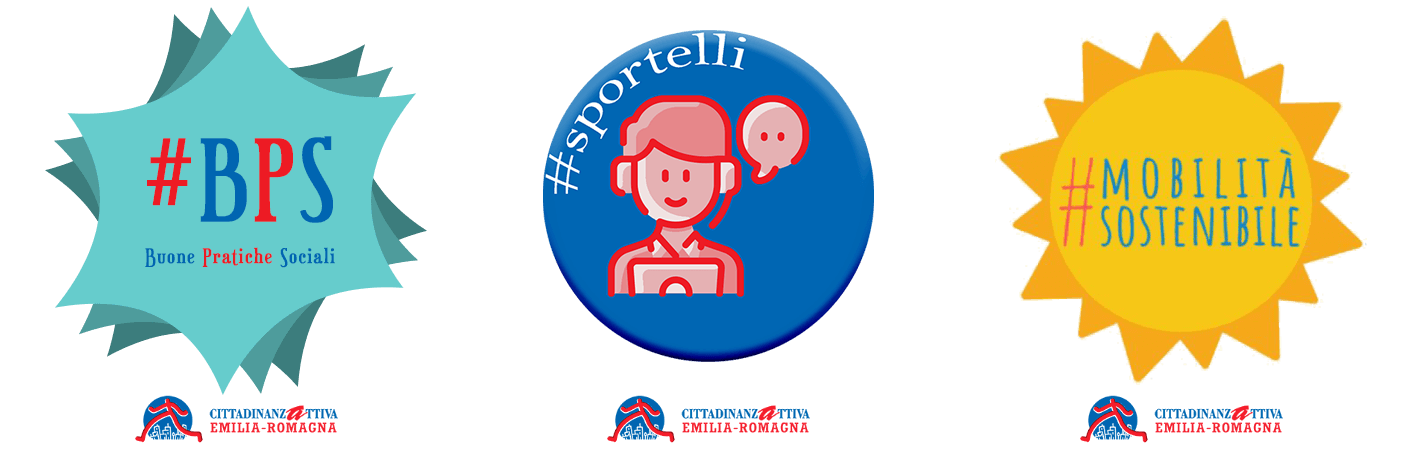di Walther Orsi
Ancora coinvolti dalla grande emergenza relativa al coronavirus, adesso siamo tutti impegnati a cercare di gestire la profonda crisi economica conseguente.
Secondo Enrico Giovannini, economista e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, non si può solo ripartire, ma bisogna andare oltre, in una prospettiva di ‘resilienza trasformativa’. Nell’intervista, condotta da Francesco Blesio (apparsa sul Corriere di Bologna del 2/04 u.s.), Giovannini afferma che “la resilienza è la capacità di una persona o di un sistema, a fronte di uno choc, di tornare a dove era prima di quello choc. Questo concetto non basta ora. Noi non vogliamo ritornare dove eravamo prima. Avevamo disoccupazione, disuguaglianze, inquinamento”. Questa crisi può essere usata per imparare a fare le cose diversamente e meglio.
Si tratta infatti di andare oltre non solo alla resilienza, ma anche alla prospettiva taumaturgica dell’innovazione, come l’abbiamo intesa finora che non è stata in grado di risolvere i grandi problemi in cui eravamo immersi già prima dell’emergenza e dell’attuale crisi.
Sì, perché politici, intellettuali, giornalisti, imprenditori, di fronte a tali problemi, hanno cercato di convincerci che si potevano risolvere attraverso l’innovazione, di solito intesa come innovazione tecnologica, organizzativa, dei processi, delle procedure burocratiche, dei prodotti. Ma anche chi è andato oltre tali approcci, introducendo il concetto di innovazione sociale, lo ha fatto quasi sempre riducendo e restringendo il significato di tale termine. Spesso viene inteso come innovazione nell’area sociale, o innovazione orientata a promuovere uno sviluppo equo, solidale, e sostenibile. Io credo non sia sufficiente.
Il paradigma dell’innovazione sociale partecipata (vedi testo “Qualità della vita e innovazione sociale”) si propone di ‘andare oltre tali concezioni’, principalmente per i seguenti motivi:
• le trasformazioni e i cambiamenti non possono coinvolgere solo il sottosistema economico, ma anche quello politico-amministrativo e socio-culturale e devono essere finalizzati principalmente al miglioramento della qualità della vita e del bene comune;
• si fa riferimento a un processo innovativo non limitato ai contesti delle imprese, delle istituzioni, delle organizzazioni, ma diffuso nella comunità, perché teso a coinvolgere l’intera popolazione, attraverso una responsabilizzazione delle persone, nel loro ruolo di cittadini attivi;
• l’innovazione si propone di valorizzare e aggregare non solo risorse economiche, tecnologiche, organizzative, ma anche risorse umane, sociali, culturali, di tempo;
• questa innovazione richiede una profonda trasformazione dei modi di pensare, e dei modelli operativi, centrati principalmente su: ribaltamenti, connessioni e condivisioni di senso;
• la profonda trasformazione dei modi di pensare, di agire e quindi di combattere la ‘coazione a ripetere’ richiede un notevole sforzo mentale che deve fare leva non solo sull’aspetto razionale, o cognitivo, ma anche su quello emotivo. E’ necessario soprattutto identificare le emozioni positive del cambiamento, il piacere della scoperta delle risorse che ciascuno ha dentro di sé, la condivisione con altri di esperienze positive e innovative.
L’innovazione sociale partecipata si propone pertanto di valorizzare sia l’intelligenza collettiva della comunità, sia di condividere emozioni positive generate dall’essere insieme protagonisti di un progetto e/o una buona pratica sociale.
L’emergenza e la crisi che abbiamo vissuto in queste settimane hanno fornito esemplificazioni di emozioni, idee, comportamenti, progetti particolarmente significativi che vanno a integrare un patrimonio di buone pratiche sociali che, in questi ultimi anni, Cittadinanzattiva Emilia Romagna ha tentato di valorizzare attraverso molteplici iniziative promozionali, culturali e in particolare con uno specifico sito.
Ritengo che tale patrimonio di buone pratiche sociali possa fornire importanti stimoli e orientamenti per promuovere processi di innovazione sociale partecipata. In questa prospettiva, alcuni percorsi esemplificativi penso siano utili per ‘imparare a fare le cose diversamente, meglio e con piacere’.
“Alla scoperta di Milano, da casa”
Questa buona pratica sociale fa riferimento a un ribaltamento di senso che la caratterizza in termini innovativi: la scoperta di luoghi caratteristici e segreti turistici non sempre richiede spostamenti, ma una semplice navigazione su internet. Ci consente di individuare altri scenari tesi a coinvolgere nuove fasce di popolazione interessate a fare turismo, seppure impedite da condizioni di fragilità e di non autosufficienza, ma anche gli enti locali, le associazioni culturali e di promozione del turismo, le agenzie turistiche.
In questo modo sarà possibile scoprire che la diffusione di un turismo virtuale, da affiancare al turismo tradizionale, è in grado di conciliare logiche e interessi diversi: il profitto di nuove attività imprenditoriali, la creazione di altre figure professionali, la tutela dell’ambiente e la riduzione del traffico, una migliore fruizione e conoscenza dei luoghi di interesse turistico, un più facile accesso a monumenti, mostre, musei, un orientamento ed una più adeguata preparazione delle visite turistiche tradizionali, il miglioramento della qualità della vita dei residenti, che molto spesso viene compromessa nei luoghi più frequentati (come ad esempio: Venezia, Firenze, Roma) da un turismo mordi e fuggi. Si darà così nuovo senso alle molteplici forme per fare turismo, condividendo anche piacevoli emozioni, ad esempio il piacere di essere protagonisti e di appartenere ad una comunità che, attraverso il turismo esperienziale, si arricchisce di nuove conoscenze e relazioni.
“L’edicola di Rossana, romantica (e resiliente)”
Questa buona pratica sociale fa riferimento a un ribaltamento di senso che la caratterizza in termini innovativi: un’edicola non rappresenta solo un luogo deputato all’acquisto di giornali, con un consumatore passivo, ma un punto di aggregazione e un servizio che valorizza le relazioni, le risorse, gli interessi, il ruolo attivo dei cittadini. Ci consente di individuare altri scenari, tesi a coinvolgere i gestori di edicola più disponibili, gli enti locali, le associazioni economiche di categoria, le associazioni culturali, le imprese che svolgono attività commerciali on line e consegne a domicilio, ma anche a scoprire nuovi ruoli professionali svolti soprattutto dai giovani.
Rigenerare l‘edicola come luogo di incontro e sede di servizi, permette di conciliare logiche e interessi diversi: la generazione di migliori profitti, la diffusione di figure professionali che possano affiancare e integrare l’attività dei tradizionali edicolanti, lo sviluppo di tecnologie innovative, la diffusione di eventi culturali nella comunità, l’attivazione di nuove forme di inclusione sociale, la responsabilizzazione dei cittadini in merito ai problemi della comunità e del territorio. Sarà così possibile dare nuovo senso alla mission delle edicole, ma anche condividere piacevoli emozioni, quali ad esempio il piacere di avere vicino a casa un punto in cui incontrare amici, essere riconosciuti e poter fare due chiacchiere liberamente.
“Co-Housing – Stradelli Guelfi”, o “Giardino dei folli”
La buona pratica sociale è orientata da un ribaltamento di senso che la caratterizza in termini innovativi: da una condizione abitativa che favorisce l’isolamento, lo spreco di risorse e la rigidità del contesto residenziale, a un modello di vita solidale e sostenibile che incentiva le relazioni di vicinato, promuove la condivisione dei beni, delle competenze, valorizzando la capacità progettuale dei cittadini e l’adattamento continuo delle risorse abitative. Questa interessante esperienza ci consente di individuare altri scenari tesi a coinvolgere gruppi di cittadini, motivati e disponibili a sperimentare nuove forme abitative, gli enti locali, le associazioni economiche di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela dell’ambiente e di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, le imprese che operano nell’ambito dell’edilizia, ma anche quelle che si occupano delle nuove tecnologie comunicative, della domotica, del risparmio energetico, di una gestione innovativa dei rifiuti.
In questo modo sarà possibile scoprire che la promozione di Co-Housing, nuove forme abitative solidali e sostenibili, case intelligenti e a geometria variabile, può consentire di conciliare logiche e interessi diversi: il profitto di nuove attività imprenditoriali e professionali, nell’ambito dell’edilizia, della rigenerazione urbana, delle nuove tecnologie, relative ai sistemi comunicativi, informatici e alla domotica, la tutela dell’ambiente e il riciclaggio dei rifiuti, lo sviluppo di esperienze di inclusione sociale, di prevenzione e lotta contro la solitudine, di nuovi interventi a favore delle persone fragili e non autosufficienti, l’attivazione di forme innovative di educazione e impegno civico dei cittadini, un migliore utilizzo delle risorse delle famiglie. Si darà così nuovo senso al proprio modo di abitare in un luogo e in una comunità, condividendo piacevoli emozioni, quali ad esempio il piacere di appartenere a un gruppo di persone con cui, insieme, si mettono in pratica i valori dell’accoglienza, dell’amicizia, della solidarietà, della sostenibilità sociale e ambientale.
Le esemplificazioni fornite spero possano aiutare a comprendere che è possibile andare oltre la resilienza e la semplice innovazione tecnologica ed organizzativa. Fare le cose diversamente, meglio e con piacere, in una prospettiva di innovazione sociale partecipata, rappresenta quindi un’operazione che non può essere delegata solo ai professionisti, alle imprese, alle organizzazioni e istituzioni, ma richiede una profonda trasformazione dei modi di pensare, di agire e quindi di combattere una diffusa ‘coazione a ripetere’. Richiede innanzitutto un impegno personale dei cittadini che non può fare leva solo su gli aspetti razionali, o cognitivi, ma anche sulle emozioni positive del cambiamento, sul piacere della scoperta delle risorse che ciascuno ha dentro di sé, sulla condivisione con altri di progetti e/o buone pratiche sociali positive e innovative.