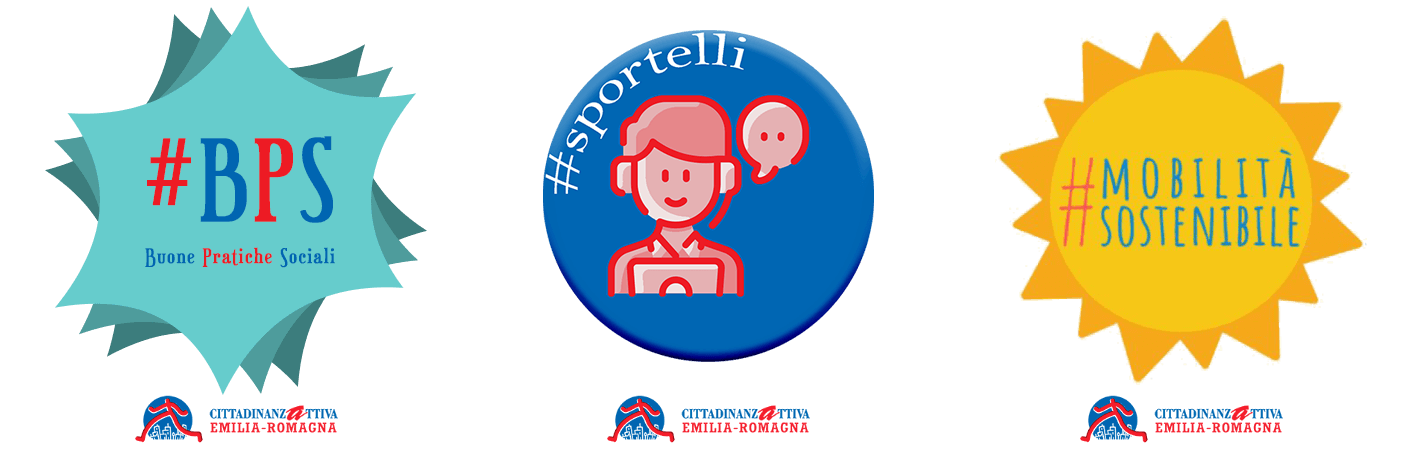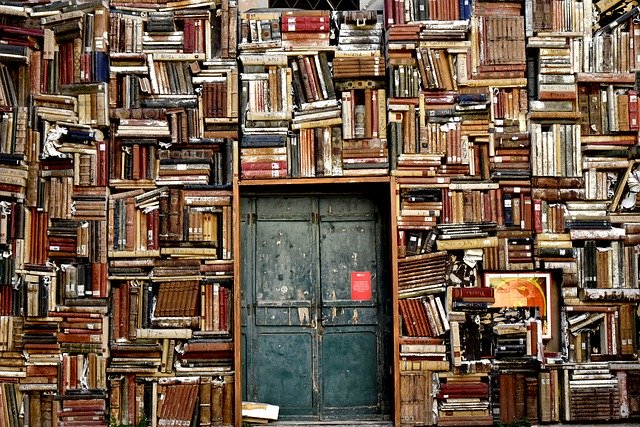(di Walther Orsi)
Durante il periodo estivo avevamo, in qualche modo, rimosso il grande problema della riapertura delle scuole. In questi giorni però è sufficiente leggere alcuni titoli di quotidiani per scoprire che tale riapertura rischia di mettere in crisi non solo i dirigenti e gli operatori della scuola, ma anche tutti gli attori coinvolti in tale operazione: enti locali, politici, amministratori, i servizi sanitari, il sistema dei trasporti, i genitori e ovviamente i bambini, i ragazzi ed i giovani studenti.
“Scuola, ripartire così è una follia” (Repubblica, pag. 12, del 24.8.2020); “La caccia a banchi e aule per 150 mila studenti” (Il Corriere della sera, pag. 2, del 25.8.2020), “Si possono affittare anche appartamenti. Ma l’esecutivo doveva muoversi prima. Giannelli (Associazione presidi): tempi stretti” (Il Corriere della sera, pag. 2 del 25.8.2020); “L’obiettivo di alzare la capienza dal 50 al 70 per cento” (Il Corriere della sera, pag. 3, del 25 agosto 2020); “Conte richiama i ministri: la scuola vi riguarda tutti. No alle Regioni fai da te” (Il Corriere della sera, pag. 3, del 25.8.2020).
Questi titoli sono emblematici di approcci e modelli interpretativi che spesso ricorrono nei mass media in Italia, caratterizzati dal ‘lamento‘, perché era necessario partire prima, dalla ‘ricerca del colpevole‘, perché gli addetti ai lavori della scuola non hanno sufficienti capacità, dalla ‘mancanza di risorse‘ perché mancano gli operatori, le aule, i banchi, dalla ‘strumentalizzazione politica‘ perché le responsabilità ricadono sempre più spesso su un ministro e un governo non adeguati.
I mass media contribuiranno ancora una volta a trasmettere l’idea che la riapertura delle scuole rappresenterà l’ennesimo fallimento italiano, salvo poi scoprire in seguito, come per l’emergenza sanitaria, che invece in altri paesi sarà andata peggio.
Non è nostra intenzione però fare il processo ai mass media, anche perché è importante comunicare in anticipo i problemi, le carenze, le difficoltà, per stimolare un processo di responsabilizzazione diffuso che ancora una volta rappresenta la condizione indispensabile per gestire al meglio il percorso di riapertura delle scuole.
Il nostro intento, invece, è quello di sottolineare quello che i mass media non riescono a mettere in evidenza: la necessità di trasformare la riapertura delle scuole e delle università in sicurezza, dopo il lockdown, in uno stimolo a cercare nuovi paradigmi di riferimento e nuovi modelli operativi, per costruire una vera e propria comunità educante.
Ancora una volta sono i cittadini, con le loro buone pratiche sociali, a fornire nuovi scenari orientati ad una più diffusa responsabilizzazione in merito a tutti i processi, gli attori, gli strumenti che concorrono, in un determinato territorio, a sviluppare e a migliorare un sistema educativo-formativo. In particolare è necessario ridefinire complessivamente la delega che finora abbiamo dato alla scuola, all’università al fine di garantire che sia l’intera comunità a riappropriarsi dei processi educativi e formativi.
Diventa fondamentale quindi attivare un percorso di invenzione sociale e di cambiamento in grado di focalizzare l’attenzione anche su altri contesti istituzionali e territoriali che possono aiutare la scuola e l’università nella loro mission.
Particolarmente significative possono essere le esperienze che fanno riferimento al Progetto Erasmus (Esperienze europee e formazione giovanile) e quelle di alternanza scuola-lavoro (Investiamo sull’Alternanza scuola-lavoro).
Le buone pratiche sociali dei cittadini hanno dimostrato inoltre che è possibile sviluppare un intervento educativo e formativo, anche fuori dalle sedi tradizionali della scuola e dell’università, coinvolgendo altri luoghi e contesti, quali ad esempio le strade, le piazze, i giardini, le imprese, i musei, le biblioteche, le chiese.
- Il bibliomotocarro
- Scuola senza frontiere: la maestra viene in camper
- Book crossing nel parco Oliviero Olivo
- Eventi ‘young friendly’ al Museo Poldi Pezzoli
- A lezione in chiesa tra organi e affreschi
Le buone pratiche sociali dei cittadini hanno messo in evidenza in particolare che è necessario coinvolgere nel percorso educativo-formativo altri attori (imprenditori, operatori sanitari, pensionati, attori, registi, operatori culturali, editori, associazioni educative); ulteriori investimenti economici, strutturali, tecnologici, culturali; altre modalità e strumenti comunicativi.
E tante altre esperienze di cittadinanza attiva forniscono esempi significativi in questo senso:
- Un libro ad alta voce per tenere viva la letteratura
- Cinnica! Libera consulta per una città amica dell’infanzia
- Un pensionato racconta una storia ai bambini
- Ostetrica in pensione sensibilizza sulla affettività e sessualità nelle scuole
- Work-lab: uno spazio di sostegno, formazione e accompagnamento alla ricerca attiva
- Una start up contro i bulli
- Ester Pantano: il mio set con i ragazzi
- Una classe da favola: i ragazzi diventano editori
Le buone pratiche sociali individuate ci forniscono importanti orientamenti tesi a promuovere un significativo processo di ‘innovazione sociale partecipata’ (Dalla resilienza all’innovazione sociale partecipata).
Ecco evidenziati gli elementi che possono trasformare la situazione di crisi del sistema educativo e formativo in un profondo processo di cambiamento che può andare ben oltre l’emergenza del Covid 19 e della riapertura delle scuole.
Il percorso di adeguamento di scuole e università, in relazione all’emergenza del Coronavirus, non può che essere l’occasione per costruire un’alleanza fra gli addetti ai lavori della scuola e dell’università e tutti gli attori sociali della comunità e del territorio che ritengono l’educazione e la formazione una questione che li riguarda. Solo attraverso un processo di responsabilizzazione diffusa, che coinvolga in primo luogo proprio i ragazzi ed i giovani, sarà possibile costruire, insieme a loro, gli scenari che possono dare speranza al futuro delle nuove generazioni.
In questa prospettiva non può che emergere anche il problema delle risorse. Ma sarebbe molto riduttivo pensare solo alle risorse economiche, strutturali, tecnologiche ed operative. Occorre promuovere una valorizzazione delle risorse umane, sociali, culturali, di tempo, che concorrono a generare nuovi incentivi, significati, motivazioni ed emozioni per tutti coloro che, insieme ai ragazzi e ai giovani, intendono investire sui processi educativi e formativi.
Affrontare la questione educativa e formativa, in un’ottica di innovazione sociale partecipata, significa però anche sperimentare nuovi modi di pensare e di agire:
- in alcuni casi, attraverso un vero e proprio ‘ribaltamento di senso‘ (ad esempio: il processo educativo e formativo inteso non solo come acquisizione di informazioni e conoscenze consolidate, trasmesse dagli adulti, ma anche come produzione di nuovi modelli interpretativi ed operativi, elaborati dai giovani in collaborazione con gli insegnanti e la comunità educante);
- in altri, attraverso la ‘connessione di logiche diverse‘ (ad esempio: l’educazione e la formazione si possono sviluppare coniugandole con gli interessi dei giovani, quali la tutela dell’ambiente, la musica, l’arte, il cinema, le nuove tecnologie comunicative, il volontariato, l’impegno civile e sociale, l’orientamento e la preparazione al mondo del lavoro);
- in altri ancora, attraverso la ‘condivisione di valori, emozioni, progetti‘ (ad esempio: l’esperienza studentesca può rappresentare un’opportunità per sperimentare il piacere di appartenere ad un gruppo di amici, ad una comunità educativa, ma anche per condividere e mettere in pratica determinati valori, quali la solidarietà, l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, per iniziare ad elaborare e sviluppare insieme progetti e percorsi imprenditoriali).