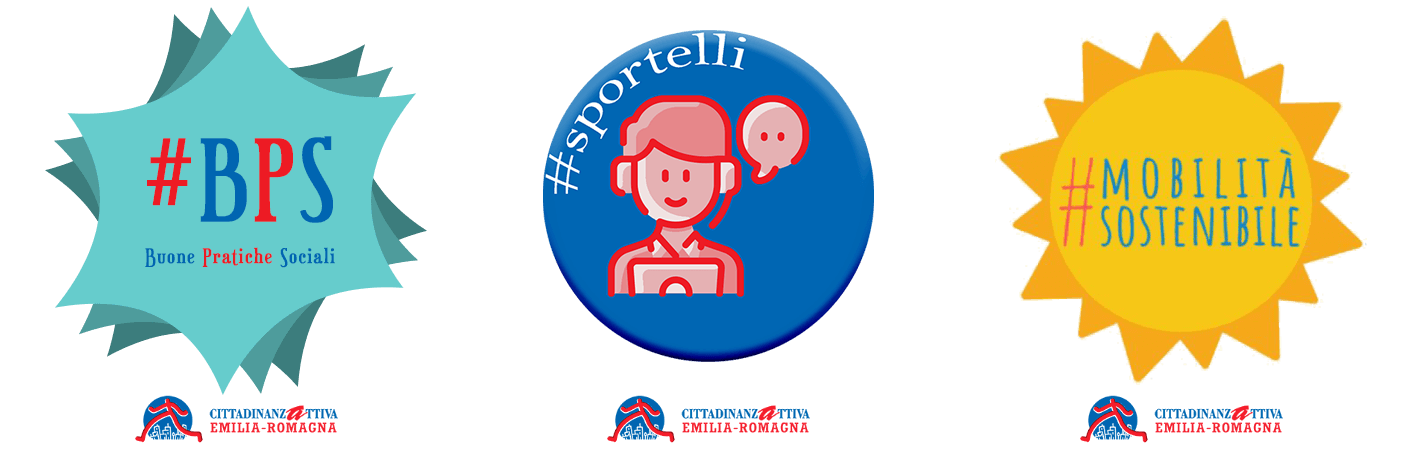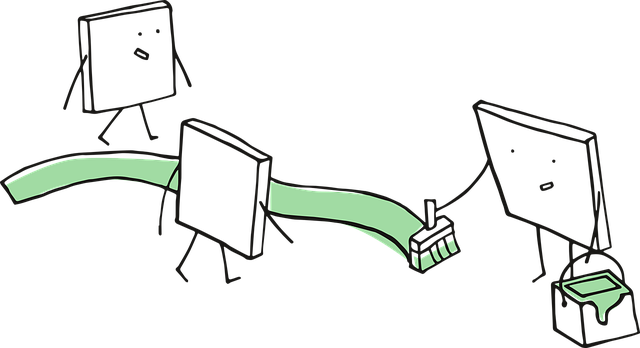di Federico Licastro
Oggi è il 25 aprile e festeggiamo segregati fisicamente la Festa della Liberazione dal nazifascismo.
Siamo ancora costretti in un confinamento temporaneo che ci priva di alcune libertà che il sacrificio di chi ci ha preceduto aveva conquistato a caro prezzo.
Il confinamento sociale è lo strumento che stiamo collettivamente usando per contenere l’infezione del virus. Non è certo uno strumento moderno, ma come sperimentiamo ormai da oltre un mese sta efficacemente abbassando il numero di contagiati e soprattutto il numero di ricoveri ospedalieri e nelle unità di terapia intensiva.
Fortunatamente da alcune settimane aumentano i guariti e si liberano posti preziosi negli ospedali del Nord Italia. Attualmente il Centro e il Sud della nostra penisola sembrano risparmiate da i numeri funesti del Nord e che hanno profondamente segnato tutti noi negli ultimi due mesi.
Sotto molti punti di vista è un’esperienza straordinaria quella che abbiamo l’occasione di vivere. In questo caso l’aggettivo straordinario vuole significare la qualità fuori dell’ordinario del nostro vissuto attuale.
Non so quanti di noi hanno la consapevolezza che l’epidemia di Covid 19 è un evento epocale che sta accomunando tutti i popoli del mondo in un’esperienza di lotta e di sopravvivenza a cui non eravamo preparati e che non ci aspettavamo di affrontare.
Questa esperienza che condividiamo con la stragrande maggioranza dei nostri simili dovrebbe rinnovare di significato un sentimento di comunità che ognuno col suo personale sentire sta percependo.
Una consapevolezza più o meno velata si fa strada fra gli strati assopiti della nostra coscienza umana: siamo dunque tutti passeggeri sull’astronave terra in viaggio nello spazio e nel tempo! Condividiamo uno spazio ambientale forse raro nell’universo che permette la nostra esistenza insieme a quella di migliaia di specie diverse di viventi con cui occupiamo questa meravigliosa palla che chiamiamo Terra.
Gli esiti di questa esperienza dolorosa causata dall’infezione non sono scontati e rimangono incerti. La pandemia passerà, ma i danni che ha indotto o esasperato rimarranno. Il modo con cui riprenderemo la nostra esistenza possibilmente senza il Covid 19 e come ripareremo i danni causati dal virus determinerà in modo pesante il nostro destino e quello di centinaia di specie ora in bilico per la sopravvivenza.
Penso che il pericolo comune che stiamo attraversando dovrebbe o potrebbe esaltare il senso di connessione che condividiamo con la “natura” o l’ambiente naturale in cui ci siamo evoluti.
Tutte le altre specie dalle più semplici alle più complesse si adattano all’ambiente naturale e ne seguono i lenti millenari cambiamenti.
I singoli individui delle speci, godendo di ciò che la natura offre, nascono, vivono, si replicano e muoiono in un ciclo apparentemente senza discontinuità. A volte capitano delle catastrofi improvvise e alcune specie perdono la loro nicchia ecologica e possono estinguersi.
E’ successo circa sessanta milioni di anni fa, ad esempio, con i dinosauri. Rettili perfettamente adattati all’ambiente in quelle ere lontane si sono estinti, perché improvvisamente sono cambiate le condizioni ambientali.
Ci sono tanti altri esempi di specie che si sono estinte e i fossili che occasionalmente scopriamo ne testimoniano l’avvenuto passaggio sul nostro pianeta.
Però noi umani siamo una specie di viventi particolare, perché abbiamo acquisito delle capacità che non condividiamo con gli altri viventi.
Nello spazio evolutivo relativamente breve che ci ha visto emergere dai nostri antenati preumani passando per gli ominidi e diventare poi homo sapiens-sapiens, abbiamo acquisito una facoltà che non condividiamo con le altre specie di viventi.
Infatti, non ci adattiamo più all’ambiente, ma abbiamo acquisito la capacità di cambiarlo.
Sfortunatamente, i cambiamenti ambientali che stiamo causando con le nostre attività tipicamente umane hanno cambiato e continuano a cambiare l’ambiente in cui viviamo con una velocità che supera i tempi dell’evoluzione naturale.
I cambiamenti ambientali “naturali” che hanno accompagnato l’evoluzione delle specie, catastrofi permettendo, si misurano in centinaia di migliaia di anni.
I cambiamenti ambientali che abbiamo invece imposto al pianeta si misuravano prima dell’avvento della rivoluzione industriale in secoli. Dopo l’industrializzazione, a causa dell’avvento delle tecnologie moderne e del sempre più smisurato bisogno di energia, l’unità di misura del cambiamento ambientale si è ridotta in anni.
Cambiano le condizioni degli ecosistemi che hanno reso un giardino il nostro pianeta azzurro. Gli ecosistemi subiscono cambiamenti che superano la capacità di adattamento delle specie che li occupano. I cambiamenti sono troppo veloci per essere compatibili con la sopravvivenza delle specie nostre contemporanee.
Infatti, sono già molte centinaia i viventi scomparsi durante il ‘900 e i primi due decenni del ventunesimo secolo. Altre specie sono in via di estinzione e altre ancora sono entrate in un cammino senza ritorno che le porterà alla scomparsa.
Ci comportiamo come degli apprendisti stregoni, poco consapevoli della potenza degli strumenti che inventiamo e soprattutto delle conseguenze che le tecnologie e il loro uso ha avuto e continua ad avere sul pianeta.
Siamo entrati in un’era che alcuni hanno definito “Antropocene”. Il termine sottolinea gli effetti spesso nefasti che le attività della specie umana sta causando all’ambiente.
In altri termini, la nostra sconsiderata attività sta sottoponendo l’intero sistema naturale ad uno stress ambientale che probabilmente supera le capacità di sopravvivenza di quasi tutte le specie nostre contemporanee.
Tutti abbiamo sentito parlare dei cambiamenti climatici che le attività umane stanno causando. Anche cambiamenti apparentemente lievi nella temperatura dei mari e dell’atmosfera possono causare drammatici cambiamenti nella maggior parte degli ecosistemi e determinare la scomparsa di moltissime specie di viventi.
Tali cambiamenti si ritorcono anche contro noi esseri umani che subiremo senza dubbio le conseguenze del mutamento climatico indotto prevalentemente dalle nostre attività fuori controllo.
Già prendendo in considerazione il solo parametro numerico occupato dalla nostra specie, viene il dubbio che il numero di noi umani è già difficilmente compatibile con la sopravvivenza delle altre specie di viventi. Abbiamo poi creato una miscela di emissioni chiamata inquinamento che sta avvelenando in modo grave gran parte del pianeta.
Che siano le attività umane le maggiori responsabili dei disastri ambientali in corso ce lo mostra anche il Covid 19. Il rallentamento delle nostre attività a causa dell’epidemia ha determinato in gran parte delle aree abitate un calo temporaneo ma significativo dell’inquinamento atmosferico.
Pur essendo tutti corresponsabili di questo annunciato disastro, la valenza e il peso delle responsabilità vanno proporzionalmente distribuite a secondo del peso economico, sociale e politico che ciascun membro della nostra comunità di umani ha avuto, ha e avrà.
Quindi, nessuno può essere assolto, ma alcuni meno di altri. Il modello di sviluppo scelto e consolidato negli ultimi cento anni si sta dimostrando incompatibile con la vita come l’abbiamo fino ad oggi conosciuta.
Quindi è ormai non più rimandabile un cambio di paradigma e di modello di crescita. Una vera e propria rivoluzione culturale che questa nuova pandemia ci sollecita a intraprendere.
Quando avremo superato il virus cosa decideremo di fare? Come avvieremo la ricostruzione economica? Quali innovazioni sceglieremo? Quali modelli sociali ci piacerà introdurre? Andremo avanti in una continuità falsamente rassicurante? Cesseremo lo scempio ambientale o cadremo ancora nella trappola dei falsi profeti che ci hanno guidato al disastro? Saremo capaci di innovare le forme di rappresentanza e dare nuova energia alle democrazie liberali? Oppure preferiremo seguire i capi come un gregge votato al sacrificio sull’altare del profitto? Il capitale si scoprirà un’anima e una vocazione sociale?
Il Covid 19 è anche un grande stress test che sta incrinando le debolezze del nostro sistema sociale, economico e politico ed è a sua volta stato generato dalle contraddizioni insite nello stile di vita prevalente e globalizzato assunto dalla specie umana.
Voi direte che non c’è connessione col disastro ambientale e l’attuale infezione da Covid 19. Sfortunatamente la connessione c’è ed è cogente.
Quando si sottopongono gli ecosistemi ad uno stress come quello che l’Antropocene sta inducendo, si causano cambiamenti anche in quelle specie invisibili che sono i batteri e i virus.
Questi microrganismi infettano ospiti abituali che, se vengono ridotti di numero perché il loro ecosistema si restringe per le distruzioni da noi indotte, subiscono una forte pressione evolutiva.
Il virus muta e salta dal suo ospite abituale in via di estinzione ad altri ospiti più numerosi.
Noi umani siamo molto numerosi, viviamo in grandi concentrazioni urbane, a stretto contatto l’uno con l’altro e ci spostiamo rapidamente da un punto del pianeta all’altro. Qualche virus mutante in cerca di nuovo ospite ci trova particolarmente appetibili. Forse è la storia dell’arrivo del Covid 19 fra noi.
Ma torniamo al nostro confinamento sociale; la nostra arma collettiva per combattere il nuovo sgradito ospite arrivato fino a noi.
Mi ha particolarmente colpito la differenza con cui alcuni governi stanno affrontando questa emergenza pandemica, le conseguenze pratiche per le popolazioni e il rapporto di queste ultime con chi le governa e amministra.
In Italia chi ci governa è ricorso al confinamento obbligatorio e costrittivo. Non si può uscire di casa, se non per casi di necessità e con una autocertificazione che ne attesti lo stato di necessità per coloro che vengano fermati dagli organi di polizia. Quindi, non una raccomandazione, ma un’imposizione con conseguenze di carattere amministrativo e penale che ha limitato la nostra libertà di cittadini.
Anche Francia, Spagna, Inghilterra e altri paesi dell’Est europeo si trovano ora nella stessa situazione.
Alti paesi hanno adottato una modalità parzialmente diversa. Ad esempio, la Germania è un paese democratico in cui il contenimento dell’epidemia è stato ottenuta con misure temporanee di isolamento e una politica di consigli alla popolazione che non ha escluso la possibilità di spostamenti individuali rispettando alcuni essenziali precetti per ridurre la circolazione del virus.
Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. La Germania per il momento ha un numero di contagiati contenuto e un numero di deceduti molto inferiore di quello dell’Italia, Francia, Spagna, Inghilterra.
Gli Stati Uniti sono più vicini alle disastrose situazioni dei paesi mediterranei che a quelli del Nord Europa.
La classe dirigente della Germania si sta dimostrando maggiormente all’altezza della gravità della situazione indotta dal Covid 19. Il rapporto con i cittadini appare diverso, si fa leva soprattutto sulla responsabilità individuale e si conta sull’organizzazione sociale nell’affrontare la pandemia.
Ospedali, tamponi, azioni sanitarie sul territorio, confinamento per i contagiati, test serologici etc.
Anche la situazione ospedaliera è profondamente diversa all’apparire del Covid 19. La Germania dispone di ben 28,000 posti di terapia intensiva e si premura rapidamente di aumentare la disponibilità di nuovi posti letto con ventilazione assistita. La sanità tedesca disponeva quindi di un numero cinque volte superiore di stazioni di terapie intensiva rispetto all’Italia.
Questa differenza aspetta risposte. Non credo che i tedeschi tenessero quei posti per precauzione; forse le autorità sanitarie tedesche non erano state così zelanti nel taglio dei posti letto ospedaliero come è capitato da noi negli ultimi venti anni.
Quindi amministratori e governanti più seri hanno effetti migliori sulla salute dei propri cittadini.
Penso che il modello tedesco di amministratore debba essere molto lontano da alcuni casi nostrani. Pensiamo alla Lombardia martoriata dal virus e dall’impreparazione e sprovvedutezza gestionale dei responsabili della sanità regionale.
E’ triste pensare come il nostro rapporto fra cittadini, governanti e amministratori si sia rattrappito durante questi decenni passati. Per venticinque anni si è alimentato uno spirito individualistico e narcisistico che ha avvilito gli onesti e spronato i disonesti ad approfittare dei grossolani buchi che si aprivano nella nostra società mal amministrata e mal governata.
La spinta culturale dominante individualistico-narcisistica ha favorito vizzi nazionali quali l’evasione fiscale massiccia che ha sottratto risorse alla sanità e ai principali servizi che un moderno paese dovrebbe dotarsi. Scuola, università, ricerca scientifica, infrastrutture e servizi evoluti alla persona sono diventate le nostre cenerentole nazionali.
L’instabilità di governo è stata forse il carattere che più ha distinto la governance nazionale.
D’altra parte, la relativa apparente stabilità nelle amministrazioni delle regioni non ha saputo nella maggior parte dei casi compensare le carenze di più alto livello. La selezione degli amministratori politici locali raramente ha seguito criteri di competenza e preparazione professionale.
La sanità divenuta di competenza regionale per una riforma dal corto respiro culturale attuata alcuni decenni fa ha declinato in forme regionalizzate il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.
Oggi ci ritroviamo una disomogeneità assistenziale fra regioni non compatibile per un paese sviluppato quale il nostro pretende di essere.
L’invasione progressiva dei partiti nella struttura economica e sociale ha avviato il disastro che oggi contempliamo, pretendendo di sostituire la competenza e la conoscenza con un distorto senso meritorio che ha posto l’appartenenza partitica come meccanismo di selezione e promozione di una classe dirigente che spesso non sa dirigere. Fortunatamente esistono delle eccezioni, ma non sono bastate a compensare il quadro negativo complessivo.
Le storture culturali e i vizzi della politica non muoiono neppure ai tempi del Covid 19. Una politica debole e che non gode la stima della cittadinanza deve comunque rispondere alle urgenze del momento. Si ricorre ai comitati tecnici e scientifici, ma con la visione distorta tipica del mondo politico italiano. Vi voglio sottoporre un esempio.
La Protezione Civile ha il compito di affrontare l’emergenza pandemica e per farlo in accordo con i decisori politici è stata affiancata da un organo tecnico scientifico che deve fornirle i suggerimenti e le linee operative necessarie.
La commissione è scelta dal commissario della protezione civile che ha nominato gli esperti che compongono il comitato tecnico scientifico a cui è delegata una serie di funzioni per combattere la pandemia provocata dal virus. Quindi, si ha bisogno di una squadra di competenze diverse e appropriate per affrontare la lotta al virus e alla pandemia.
Abbiamo dunque la squadra giusta? Per rispondere alla domanda dobbiamo vedere chi sono i principali componenti e valutare quanto il curriculum professionale di ciascuno corrisponda in modo congruo ed efficace all’emergenza pandemica.
Prendo in considerazione i componenti della commissione tecnico scientifica a sostegno della protezione civile che hanno avuto anche una maggiore esposizione mediatica in funzione del loro ruolo in queste settimane.
Il presidente della commissione è il prof. Silvio Brusaferro, in passato è stato professore di igiene all’università di Udine e divenuto da poco Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. E’ stato Direttore SOC Accreditamento, Gestione Rischio Clinico e Valutazione delle Performance sanitarie dell’Azienda Sanitaria Universitaria di Udine; membro del Comitato di Indirizzo dell’attività internazionale in campo sanitario, sociosanitario e per l’integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari italiani e sloveni della Regione FVG (dal 2017); membro dell’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso AGENAS – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali (dal 2018); membro dell’Organismo Tecnicamente Accreditante del SSR del FVG (dal 2018). Rappresentante per l’Italia presso ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control (Stoccolma) quale “Alternate to National Focal Point for Healthcare – Associated Infections” (dal 2015); membro del Consiglio Superiore di Sanità assegnato alla terza sezione (2010 al 2013). Come attività di ricerca nel suo CV segnala i seguenti argomenti: management nella sanità pubblica nazionale ed internazionale, miglioramento della qualità e accreditamento nelle organizzazioni sanitarie, rischio clinico e sicurezza del paziente nelle organizzazioni sanitarie, prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’Antimicrobical Stewardship, sviluppo delle reti sociali a supporto della salute.
Un curriculum interessante, ma a mio avviso il prof. Brusaferro sembra avere competenze appropriate per una gestione ordinaria della sanità pubblica meno per affrontare una pandemia nazionale come quella da Covid 19.
Altro membro di spicco del comitato è il Prof. Franco Locatelli, professore universitario di pediatria presso l’università di Pavia e Direttore del Dipartimento di Oncoematologia pediatrica del Bambin Gesù di Roma. E’ anche divenuto recentemente Direttore del Consiglio Superiore di Sanità presso il Ministero della Sanità. il Prof. Franco Locatelli ha un curriculum scientifico molto qualificato, ma focalizzato sull’onco-ematologia pediatrica di cui è un esperto in campo internazionale.
La pandemia però è una malattia infettiva non un tumore e per fortuna il Covid 19 sta risparmiando i bambini.
Altro membro della commissione è il Dr. Raniero Guerra in forza al Ministero degli Esteri italiano; è stato Direttore Sanitario in Friuli e poi ha lavorato per WHO occupandosi di problemi sanitari come Direttore medico per la Giordania, Egitto, Palestina, Libano e Siria. Infine, è stato addetto scientifico presso l’ambasciata italiana negli Stati Uniti.
Mi chiedo come il dr. Guerra possa avere un ruolo di spicco nella gestione dell’attuale emergenza virale.
Altro componente del comitato è il Dr. Claudio D’amario ex Direttore Generale dell’ASL di Pescara e nominato nel 2018 dalla ministra Beatrice Lorenzin Direttore del Dipartimento Generale del settore Prevenzione al Ministero della Salute. Forse è arrivato un po’ tardi per la prevenzione della pandemia e anche questo componente non sembra avere competenze specifiche di spicco per affrontare l’emergenza virale in atto.
Mi fermo qui. Il punto che vorrei sottolineare che in un qualsiasi comitato tecnico scientifico per un determinato problema è bene mettere personaggi con comprovata esperienza professionale in quel campo specifico ed in campi ad esso strettamente correlati. Un esperto se messo in un campo non di sua stretta conoscenza diventa un non specialista e un pesce fuor d’acqua.
Per la politica italiana però questi concetti sono ancora nel campo della fantascienza.
Abbiamo tutti assistito alle delibere del comitato tecnico scientifico prese in ritardo, contradette da quelle successive e i continui tentennamenti nella gestione dell’attuale situazione.
Le mascherine e gli altri presidi di protezione sono mancati dove erano più necessari. I tamponi sono stati eseguiti in modo non sufficiente, con gravi ritardi e non fatti ai settori di cittadinanza che maggiormente ne necessitavano (medici e operatori sanitari, individui fragili, RSA).
La medicina del territorio non ha avuto per i primi due mesi nessun coordinamento e nessun presidio di protezione, quindi, non si sono utilizzati in modo razionale i medici di medicina generale.
Il conflitto di competenze fra il potere centrale e quelli regionali è diventato molto frequente e ha contribuito alla confusione della gestione dell’emergenza. Sfortunatamente però i governatori regionali non sempre si sono mostrati all’altezza.
A esempio, in Lombardia abbiamo visto un presidente della regione e il suo assessore alla sanità che hanno detto e fatto tutto e il contrario di tutto. La magistratura indaga sul disastro delle RSA lombarde, aspettiamo fiduciosi i risultati delle inchieste promosse.
I comitati tecnico scientifici nazionali o regionali non sembrano certo il concentrato di reali esperti di cui abbiamo bisogno. Scarseggiano o sono assenti immunologi, infettivologi, epidemiologi, esperti in terapie antivirali, esperti di “big data” e analisi statistiche o altre competenze utili.
Si comprende, quindi, che il discorso che dai politici e dagli “esperti” va ai cittadini non sia mai chiaro e non chiarisca i dubbi che la difficile situazione fa sorgere.
Dobbiamo però sottolineare che nelle regioni dove i danni sono al momento più contenuti lo si deve a situazioni di dialogo proficuo fra esperti con reali competente e politici che hanno voglia di ascoltare. Esempi di questo tipo nel Nord Italia sono stati il Veneto e in parte l’Emilia-Romagna.
La politica era debole prima del virus e non si è certo rafforzata con l’epidemia, perché rimane in larga parte incapace di abbandonare i vizzi che ne hanno determinato il distacco dai cittadini.
A questo punto viene dubbio. Forse questi elementi politico, sociali e gestionali hanno contribuito a rendere meno efficiente al momento la gestione dell’emergenza da noi rispetto alla Germania?
Le scelte che un sistema paese/nazione introduce sono decisive non solo per la gestione ordinaria della vita civile ma anche per affrontare le emergenze.
Cosa faremo quando saremo usciti dalla fase più drammatica della pandemia, entrando nelle mitiche fasi due e tre?
Continueremo ancora a sopportare un sistema paese evanescente e inconcludente che ha bisogno della coercizione per contenere il virus? Quante risorse stiamo già sperperando nella gestione disordinata di questa emergenza? Emergerà una cittadinanza più attiva che si riappropri della vita civile, voglia svolgere un ruolo nuovo nella politica e che chieda e ottenga forme più idonee di rappresentanza politica?
Queste sono solo alcune delle domande che ogni cittadino dovrà porsi e trovare le risposte.
Ciò di cui abbiamo bisogno è soprattutto un patto fiduciario rinnovato fra cittadinanza e istituzioni, se collettivamente vorremo uscire rinnovati dalla pandemia e costruire un’Italia in rinnovamento in una nuova Europa e in un mondo meno irrazionale.
Foto di Manfred Steger da Pixabay